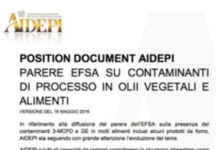Il 13 maggio 2015 l’eurodeputato Paolo De Castro – già ministro italiano per l’agricoltura – ha presentato alla Commissione europea un’interrogazione su un tema che a prima vista appare molto tecnico, ma ha risvolti di grande rilievo per la salute dei consumatori e l’economia di una filiera produttiva ancorata al territorio nazionale. Si tratta di un additivo, l’acido tartarico.

L’acido tartarico di origine naturale
L’acido tartarico è una sostanza di origine naturale estratta dalle fecce del vino – vale a dire, ciò che deriva dalla spremitura delle uve – ove è presente in forma di sale di potassio. È da sempre impiegato nelle produzioni alimentari e vinicole, i dentifrici, i prodotti dell’industria farmaceutica e altri prodotti di consumo, oltreché in alcuni materiali per l’edilizia. Nel settore alimentare, il tartarico viene aggiunto a un’ampia gamma di prodotti a partire dal latte per neonati, le caramelle, le marmellate e i succhi di frutta, cui conferisce un gusto acidulo. Negli agenti lievitanti per pane e dolci, come antiossidante ed emulsionante. Nel vino, per equilibrarne l’acidità.
L’invasione del prodotto di sintesi: benzene da OGM
Nell’ultimo decennio è tuttavia comparso sul mercato un acido tartarico sintetico, di provenienza asiatica, un sottoprodotto della reazione chimica derivato del benzene grazie a un enzima OGM (1). Già nel 1977 alcuni studi avevano dimostrato la tossicità di una forma del tartarico di sintesi, che tende ad accumularsi nei reni portandoli a nefrosi (2). E il Comitato Scientifico dell’Alimentazione Umana ne aveva perciò escluso l’utilizzo negli alimenti, in Europa, nel 1991.
Il ritardo europeo
La chimica è frattanto evoluta, ma le procedure europee non ne hanno seguito il ritmo. Le tecnologie più moderne hanno infatti consentito di ridurre – ma non di escludere del tutto – la residuazione della forma pericolosa del tartarico di sintesi. A ben vedere, lo ‘Institute for Health and Consumer Protection’ (‘Physical and Chemical Exposure Unit’) aveva riconosciuto che ‘l’eventuale presenza dell’isomero D di acido tartarico e di metalli pesanti rende l’acido tartarico L prodotto tramite biosintesi non adatto per usi alimentari o farmaceutici’. Ma i pur recenti regolamenti europei sull’utilizzo degli additivi negli alimenti (3) e nei materiali destinati a venire a contatto con essi (4) non distinguono l’acido tartarico naturale rispetto a quello di sintesi, poiché ancora si basano su studi che risalgono a un’era anteriore.

De Castro: la CE autorizzi nuovi studi
L’onorevole Paolo De Castro ha intercettato il pericolo, ed è perciò subito intervenuto. “É assolutamente necessario ed urgente che la Commissione Europea autorizzi ulteriori studi intesi a valutare innanzitutto il profilo di sicurezza dell’acido tartarico sintetico per poi valutare se questo non debba essere escluso quantomeno dagli usi alimentari e farmaceutici”, spiega l’ex-ministro italiano per l’agricoltura a Great Italian Food Trade (www.greatitalianfoodtrade.it). E aggiunge, “alla tutela della salute dei cittadini, si affianca il problema della concorrenza sleale subita dalle imprese produttrici di acido tartarico naturale europee – proprio l’Italia è leader mondiale nella produzione di acido tartarico naturale – che sono costrette a sopportare costi di produzione molto più alti legati alla stringente normativa europea in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro”.
Il nostro eurodeputato ha scoperchiato il vaso di Pandora – a quanto si direbbe – sulle ingorde speculazioni dei grandi importatori e trasformatori di ingredienti, che potrebbero aver sostituito il prezioso acido tartarico naturale con la sua copia sintetica di ben altro valore. Destreggiandosi tra le lacune normative, e le manchevolezze della Commissione europea. La quale ora deve adottare misure immediate per tutelare sia la salute dei consumatori, sia le imprese di trasformazione tendenzialmente ignare dei risvolti tecnici e dei pericoli sottesi.
(Dario Dongo)
Note
(1) Dal punto di vista tecnico, l’acido tartarico di sintesi deriva dall’anidride maleica, a sua volta ottenuta per ossidazione del benzene o del n-butano attraverso una fermentazione con un enzima modificato geneticamente
(2) Si segnala il ‘Summary of toxicological data of certain food additives’, pubblicato nel rapporto del 21′ incontro del ‘Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives’, a Ginevra, 18-27 aprile 1977
(3) Reg. UE 1129/2011 della Commissione europea, dell’11.11.11, ‘che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari’
(4) Reg. UE 174/2015 della Commissione europea, del 5.2.15, ‘che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari’