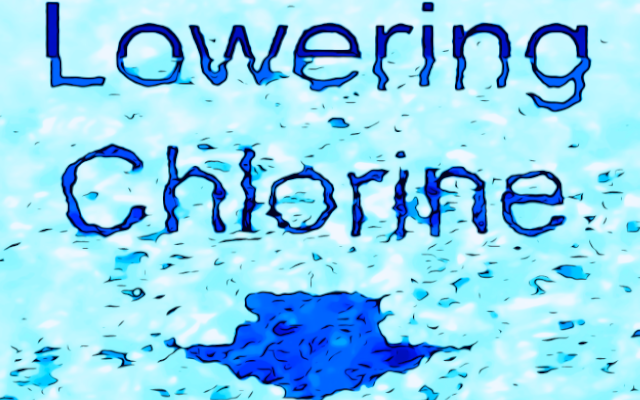I clorati nelle acque potabili – e così, in alimenti e bevande – presentano rischi per la salute. Quattro anni dopo il monito dell’Efsa sui pericoli per neonati e bambini, la Commissione definisce i limiti da applicare sulle diverse categorie di alimenti e bevande. L’ABC a seguire.
I clorati nella filiera alimentare. Acqua potabile, cibi e bevande
I clorati sono sottoprodotti inorganici della disinfezione chimica delle acque mediante cloro e suoi composti (diossido di cloro, ipoclorito). La loro formazione è influenzata da tipo e dose del disinfettante impiegato e della sua azione residua (residuo di disinfezione). Nonché da altri fattori come pH e temperatura, i costituenti dell’acqua, la concentrazione e le proprietà della materia organica ivi presente.
Il clorato negli alimenti può residuare per diverse cause:
– acqua potabile della rete idrica, utilizzata nei processi di lavorazione (a partire dal lavaggio di ortofrutta e materie prime agricole e confezionamento),
– acque di processo, allorché sottoposte a clorazione per abbatterne i livelli di contaminazione microbiologica (in particolare quando provengano dai pozzi),
– carry-over dei residui di biocidi impiegati per disinfettare macchinari, utensili e superfici adibiti alla lavorazione degli alimenti,
– coadiuvanti tecnologici e additivi (non ammessi in UE) su farine, carotenoidi e altri pigmenti naturali, sbiancante per gli amidi modificati. Cloro e composti possono venire usati nella lavorazione di carta e cartone per imballaggi. (1)
Alcuni pesticidi (con funzioni erbicida, fungicida e disseccante) a loro volta contengono clorato di sodio. Il loro impiego in UE – ma non in altri Paesi da cui l’Europa importa derrate agroalimentari – è stato vietato nel 2008 (con effetti a partire dal 10.5.10).
Cloriti e clorati, regole (disapplicate) in essere
I cloriti, così come i clorati, sono sottoprodotti non volatili derivati dalla disinfezione con biossido di cloro (DBPs, Disinfection By-Products). L’Organizzazione Mondiale per la Salute (OMS) ha raccomandato una soglia per clorati e cloriti nelle acque potabili (0,7 mg/l). (2) ll regolamento europeo che definisce i limiti massimi di residui (LMR) di pesticidi in alimenti e mangimi stabilisce invece un limite generale di 0,01 mg/kg, che si applica a tutte le sostanze – come cloriti e clorati – in relazione alle quali non sia stabilita un’apposita soglia specifica. (3)
L’acqua potabile ricade però a sua volta nella definizione di alimento ed è inconcepibile che su di essa venga tollerato un limite di contaminazione chimica 70 volte superiore a quello ammesso sulla generalità degli alimenti. (4) Tale ultimo rigoroso limite, d’altra parte, è riferito alla presenza di residui di clorati che derivino da antiparassitari e non anche da diverse altre fonti. (5) E se da un lato è la stessa acqua potabile di processo a rappresentare la prima fonte di contaminazione, è d’altro canto impossibile distinguere tra le diverse fonti di clorati la quota-parte che possa derivare da residui di pesticidi in agricoltura (frattanto vietati in UE).
Le regole in essere sono dunque contraddittorie e disapplicate al tempo stesso. Su 1087 campioni di frutta, ortaggi e cereali prelevati nell’intero territorio tedesco nel 2012-2013, 266 hanno rivelato la presenza di clorati in misura variabile tra 0,01 e 0,27 mg/kg. Con un livello medio di contaminazione dei campioni positivi alla sostanza, 0,022 mg/kg, di poco superiore al doppio del limite legale. I livelli più alti hanno riguardato pompelmi USA, peperoncini ugandesi e varie derrate dalla Cambogia (fagioli, broccoli, basilico e coriandolo). (6)
La Commissione europea ha quindi incaricato l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa) di eseguire un’analisi sulla presenza di clorati negli alimenti e sui possibili rischi per la salute pubblica associati alla sua esposizione.
Clorati negli alimenti, la valutazione scientifica dell’Efsa
L’EFSA ha ultimato la propria indagine nel 2015, pubblicando un’apposita valutazione scientifica ove si rileva che gli attuali livelli di clorato nell’acqua potabile e negli alimenti sono troppo alti rispetto agli obiettivi di sicurezza alimentare definiti in Europa. Con impatto negativo, in particolare, sulla salute di neonati e bambini.
‘L’inibizione dell’assunzione di iodio negli esseri umani è stata identificata come l’effetto critico per l’esposizione cronica al clorato. (…) La formazione di metaemoglobina è stata identificata come l’effetto acuto critico del clorato. (…) Le esposizioni croniche sono particolarmente preoccupanti nei gruppi di età più giovane con carenza di iodio lieve o moderata.
Supponendo una concentrazione di clorato di 0,7 mg / kg per tutti gli alimenti e l’acqua potabile consumati in un giorno, le esposizioni acute aumenterebbero fino a circa 5 volte e l’ARfD (Acute Reference Dose) in neonati e bambini e, al 95esimo percentile, anche in altri minori e adulti’. (7)
Precedenti studi citati dall’OMS evidenziano un rapporto tra la qualità dell’acqua potabile e l’insorgere di cancro alla prostata, all’intestino e al retto. Il 9% di tutti i casi di cancro alla prostata e il 15% di cancro rettale sono attribuiti ai sottoprodotti clorurati dell’acqua potabile (Morris, 1992). Un altro studio ha mostrato il sensibile incremento del rischio di cancro alla vescica (1,8 volte maggiore) a seguito di esposizione prolungata (30 anni) ai sottoprodotti di acque potabili trattate con cloro o clorammine (Mc Gehinn, 1993).
Altri studi confermano l’esistenza di un rapporto fra l’esposizione di lunga durata ai sottoprodotti della disinfezione ed il rischio di tumore alla prostata (Kogevinas, 2003).
Un ampio studio condotto in Norvegia tra il 1995 ed il 1998, che ha considerato 285.631 nascite, ha poi associato l’esposizione a sottoprodotti della disinfezione durante la gravidanza e disturbi alla nascita (cuore, sistema respiratorio e tratto urinario), con incremento del rischio in seguito a esposizioni più elevate. (8)
Il clorato proviene soprattutto, secondo Efsa, dall’acqua potabile che ne è di gran lunga il principale contributore. Oltreché dai disinfettanti a base di cloro, ampiamente utilizzati nel rispetto delle regole vigenti per trattare le acque e lavorare gli alimenti.
Clorati, nuovi limiti UE in arrivo
A seguito del parere EFSA la Commissione europea ha varato un piano d’azione generale. Con il duplice obiettivo di ridurre l’esposizione alimentare ai clorati e risolvere il problema della sistematica inosservanza dei LMR previsti dal regolamento sui pesticidi. Il piano d’azione prevede:
– l’impostazione di un livello massimo di clorato nell’acqua potabile,
– la raccomandazione di buone pratiche di igiene alimentare per ridurre il clorato proveniente dai disinfettanti clorurati,
– la predisposizione di LMR per il clorato negli alimenti,
– il mantenimento del limite più restrittivo (0,01 mg/kg) per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.
A gennaio 2019 la Commissione europea ha finalmente presentato uno schema normativo atto a definire i LMR di clorati per specifiche categorie di alimenti. (9) La proposta si basa sul monitoraggio compiuto da EFSA tra il 2014 e il 2018 e mira a fissare LMR provvisori per i clorati, secondo il principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Vale a dire, al 95% dei dati di occorrenza che riflettano i livelli realisticamente realizzabili applicando buone pratiche igieniche.
I limiti provvisori saranno soggetti a riesame entro i cinque anni dalla pubblicazione della proposta di regolamento. Alla luce di ulteriori progressi compiuti dagli operatori del settore alimentare per ridurre i livelli di contaminazione o in qualsiasi momento, allorché siano disponibili nuove informazioni e dati che giustifichino una revisione.
Si annota come l’inquadramento di questo tema nella legislazione sui pesticidi risulti ontologicamente problematico, poiché il contaminante in esame – come evidenziato dall’Efsa – proviene da una pluralità di fonti. A maggior ragione in quanto l’immissione nell’ambiente di sostanze derivate dal cloro e i suoi composti non è dovuta (almeno in Europa, da 9 anni) all’impiego di pesticidi in agricoltura. Quanto piuttosto alla clorazione delle acque, nelle reti idriche a gestione pubblica in primo luogo.
Clorati, prevenzione e compliance
La prevenzione è alla base del sistema proposto dall’OMS nei c.d. ‘water safety plans’ a cui è ispirata la stessa disciplina europea sulla qualità delle acque (dir. 98/83/CE). Si deve perciò lavorare all’identificazione delle potenziali fonti di contaminazione per rimuovere le cause di non conformità, rimuovendo anzitutto il materiale organico dall’acqua, prima di applicare la disinfezione.
Ai metodi classici di trattamento delle acque destinate al consumo umano si sono aggiunte, negli ultimi decenni, alcune tecniche (micro-, ultra-, nano- filtrazione, trattamenti elettromagnetici e biofisici). I quali presentano, sotto il profilo igienico-sanitario, alcuni vantaggi tra cui affidabilità e praticità di impiego, minore necessità d’impiego di prodotti chimici. Nei quasi due secoli trascorsi dall’avvio della sperimentazione del cloro nelle reti idriche, la ricerca è insomma proseguita (sebbene il ‘metodo classico’ sia ancora dominante).
La sanificazione delle condotte mediante composti del cloro tra l’altro, oltre a presentare i problemi di sicurezza alimentare sopra accennati, ha costi rilevanti per acquisto e movimentazione delle sostanze. E proprio in Italia sono stati sviluppati sistemi in grado di ridurre la disinfezione chimica in misura anche drastica. Grazie a sensori a contatto con i fluidi che analizzano in tempo reale la frequenza batterica lungo la linea. In questo modo la centralina attiva la clorazione solo quando i batteri formano colonia (prima che essa vada in maturazione e i patogeni si distacchino dal biofilm), per il tempo strettamente necessario, anziché a ciclo continuo.
Dario Dongo
Note
(1) Cfr. EPA, Environment Protection Agency, USA (1983), ‘Sodium chlorate: exemption from the requirement of a tolerance’. CMA, Chemical Manufacturers Association, USA (1989), ‘A review of the uses, chemistry and health effects of chlorine dioxide and the chlorite ion’. FDA, Food & Drink Administration, USA (1990), ‘Food and drugs’. Vol. 21, Parts 170–179
(2) Le linee guida OMS, nella loro quarta revisione (2011), su https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/
(3) V. reg. CE 396/05, ‘concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale’, testo consolidato
(4) Cfr. reg. CE 178/02, General Food Law, articolo 2
(5) Cfr. reg. CE 396/05, art. 14.2.b
(6) Cfr. Ingrid Kaufmann-Horlacher, Ellen Scherbaum, Dr. Diana Stroher-Kolberg, Cristin Wildgrube ‘Chlorate Residues in Plant-Based Food: Origin Unknown’. CCVA Stuttgart (2014)
(7) EFSA Panel on Contaminants in the food chain (CONT). (2015). ‘Risks for public health related to the presence of chlorate in food’. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2015.4135
(8) Cfr. WHO, (2005), ‘Chlorite and Chlorate in Drinking-water, Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality’
(9) Mediante integrazione del reg. CE 396/05, Allegato III, Parte A, con un’apposita colonna di dedicata a ‘chlorate’ nelle varie categorie di alimenti
Dario Dongo, lawyer and journalist, PhD in international food law, founder of WIISE (FARE - GIFT - Food Times) and Égalité.